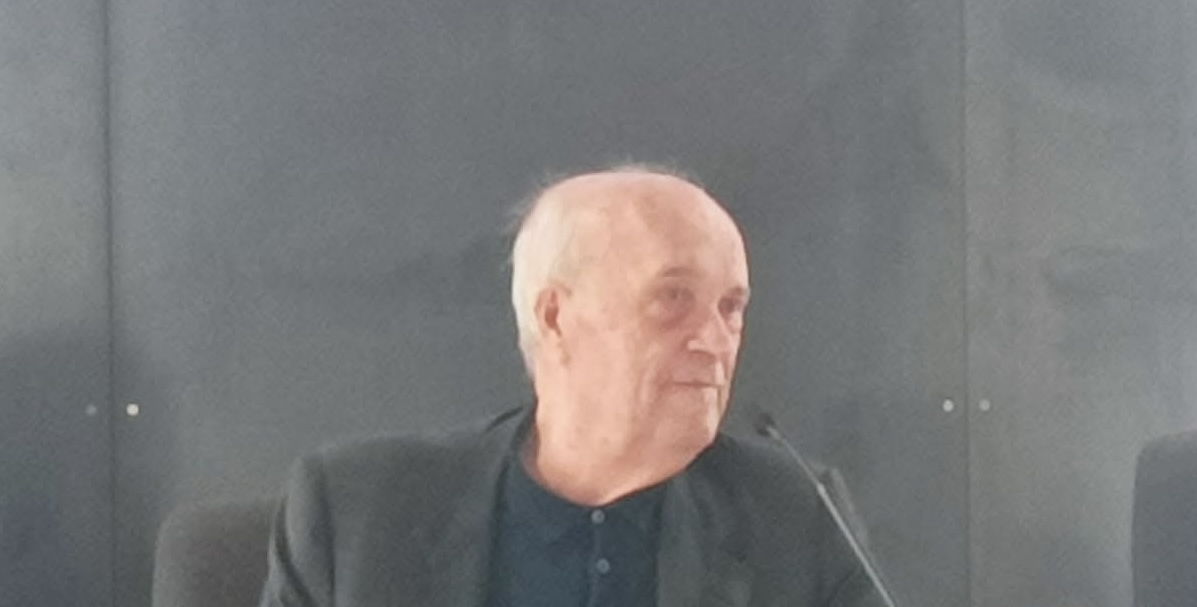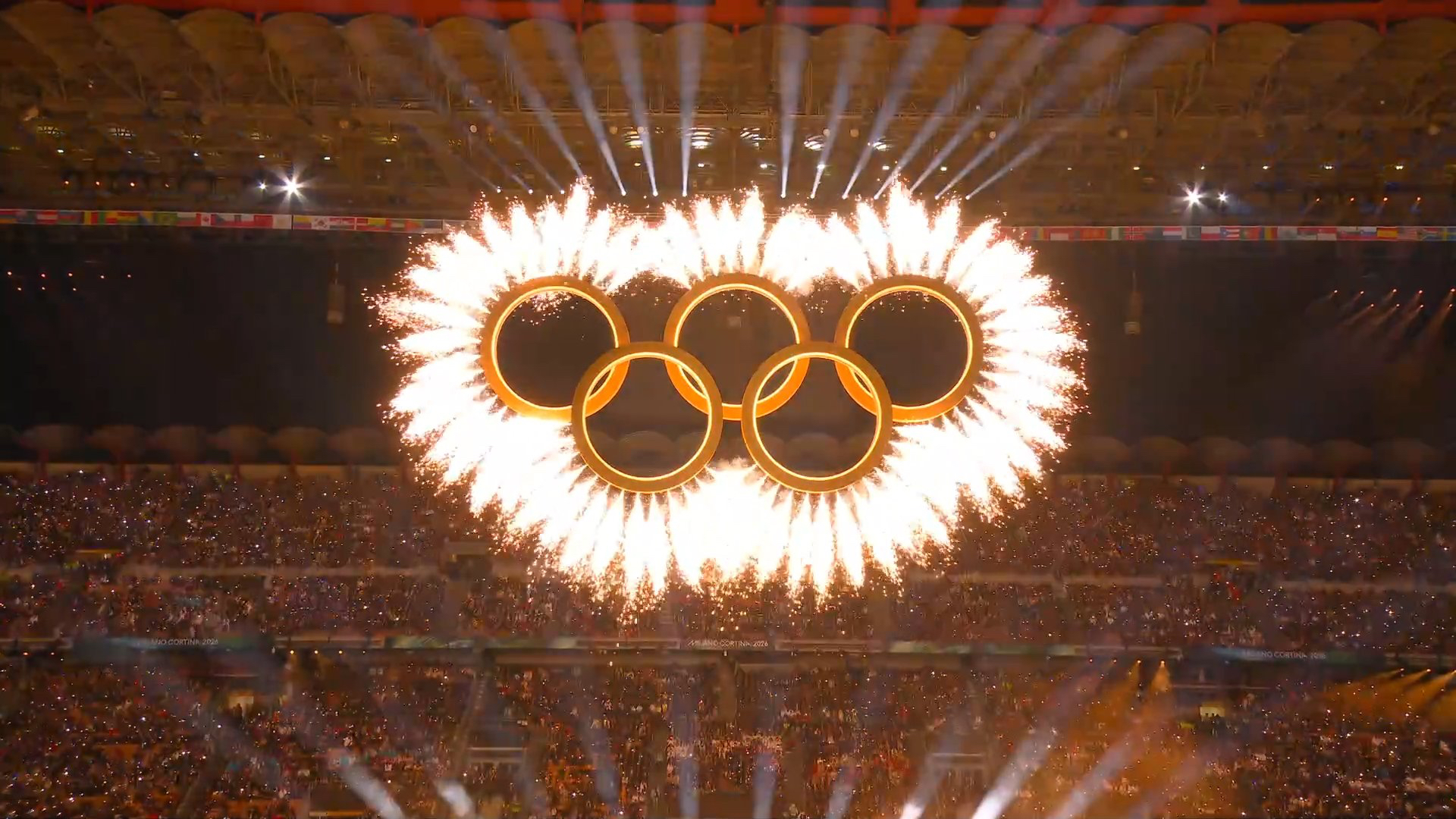L’arbitro come parte necessaria e integrante del calcio, ma soprattutto come compagno di gioco dei calciatori e non come ostacolo, avversario o addirittura «nemico». Questa la grande lezione che ha fornito Paolo Casarin, intervenuto giovedì 9 ottobre a Palazzo Bassi Rathgeb in occasione del IV Convegno dell’Academic Football Lab organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, con il titolo di «Calcio e futuro. Scenari, regole, linguaggi». Un evento di grande importanza, inteso come appuntamento di riferimento per rilanciare e consolidare il dibattito culturale e accademico che il mondo del pallone può generare. Diversi e variegati i relatori che sono intervenuti, tutti uniti dall’intento di indagare sul futuro del calcio come fenomeno sociale, culturale ed economico.
Quasi sconfinato, da questo punto di vista, il bagaglio di esperienza, aneddoti e testimonianze che Paolo Casarin ha potuto mettere sul tavolo. Lui stesso, arbitro di lunghissimo corso in Serie A e poi a livello internazionale per UEFA E FIFA (che peraltro lo elessero nelle commissioni arbitrali fino al ruolo di designatore ai Mondiali di USA ’94, mentre in Italia ricoprì lo stesso ruolo per A e B dal 1990 al 1997) ha inquadrato il suo percorso sin dall’inizio. Ossia dalla nascita, in un contesto che già in tenera età avrebbe potuto condurlo molto lontano.
«Ho sperimentato il calcio lavorando – ha spiegato Casarin -. Sono nato nel 1940, il che significa che ho vissuto la guerra. Un’esperienza che, fatalmente, insegna cose. Abitavo a Mestre, luogo molto bombardato, e nel 1945 non avevamo possibilità di vivere. Il destino doveva portarci in Argentina, eravamo già a Genova per imbarcarci. Ma trovarono una sistemazione per mio padre come falegname a Mestre. Il passaggio della guerra non è da poco, e non lo è vederla o viverla sulla propria pelle. Un ragazzino diventa una persona diversa, attenta e bisognosa di giocare. E proprio il gioco è ciò che ha fatto nascere il calcio. Quindi sono venuto a galla con questa voglia di misurarmi, far parte di un gruppo che giocava».
«Questo è il moto e il modo che ha fatto nascere il calcio», ha proseguito Casarin, per poi illustrare come la componente ludica, aggregativa e popolare della disciplina la caratterizzi sin dai primordi: «In Inghilterra, ai tempi della regina Vittoria, il rugby era già molto importante, ma mancava lo sport popolare. Così è nato il calcio, uno sport più difficile perché praticato senza mani. Ma all’epoca non sapevano che la contesa avesse bisogno di scarpe particolari per non farsi male. Erano spaventose, pericolose, tanto che a Liverpool le hanno migliorate e poi hanno creato i parastinchi nel 1874. La partecipazione era grande, si pensi che nel 1880 furono 70mila gli spettatori della primissima Inghilterra-Scozia. Finì 0-0. Nacque già allora la preoccupazione di generare spettacolo, ma si faceva gruppo in maniera straordinaria. Questo aspetto fu determinante per sviluppare ulteriormente il calcio, che però aveva bisogno di rendersi autonomo. Arbitro incluso».
Infatti i pionieri britannici del calcio non avevano inizialmente nemmeno concepito l’esigenza di introdurre un direttore di gara. Casarin ha spiegato perché: «All’epoca l’arbitro non serviva, perché di calcio ne sapevano di più i giocatori di lui. Erano quindi i due capitani, di fronte a un fallo, a riunirsi per determinare chi avesse torto. L’autonomia era totale, anche nel giudizio. Ma nei campi minori, dove a scopo ricreativo giocavano le squadre delle fabbriche, gli spalti si riempivano di fidanzate, mogli, ma anche di ragazzini curiosi. Da qui, nel 1895, si capì che non bastavano più i capitani e serviva un arbitro. Più due persone, che si rivelarono necessarie perché anche le linee erano diventate importanti».
Casarin ha però inquadrato un errore che ha determinato la visione generale e, se vogliamo, l’impopolarità della figura dell’arbitro fino ai giorni nostri: «Anche l’arbitro gioca, pur dando ordine e regole. Lo straordinario errore fu affidare questo ruolo a una persona che sapeva guardare, ma non giocare. E gli diedero oltretutto l’arma del comando, del despotismo. Se l’arbitro dice una cosa è così, stabilirono. Per cui per oltre un secolo è stata una figura detestata. I falli si erano nel frattempo ridotti in base a un dogma che si chiama spirito del gioco, e a quel punto il calcio si apriva a chiunque. E quindi non poteva che essere uno sport per tutti, indipendentemente dalle classi. Ciò apriva all’arrivo di tutti». Ma proprio questo aspetto era destinato a cambiare ulteriormente non troppo tempo dopo.
«In qualche decennio, con il calcio ormai formato, si erano definite le regole. Anche su più piani – ha ricordato Casarin -. Finita la guerra si ricominciò. Il calcio assorbì e spinse tutto, tutte le squadre volevano il giocatore delle altre. L’errore fondamentale, nel 1959, si concretizzò con una relazione in cui Gaetano Zappalà stabilì cosa fosse l’arbitro. Doveva avere mente eletta, cervello superiore, essere di classe agiata e vivere in una condizione economica di benessere. Questo ha arrestato per molti anni l’appartenenza dell’arbitro al gioco. Io, quando ero alle prime armi, conobbi e divenni amico di Cereser, Bedin e Ferrari, tutti calciatori di Serie A. Loro mi aiutarono a diventare arbitro, perché con loro giocavo. Non ero contro. E invece a livello generale si era creata discordia tra arbitri e giocatori, situazione che è rimasta la stessa fino a poco fa e talvolta ancora c’è. Ma perché l’arbitro, quando divenne tale, fu presentato come una figura di potere, autoritaria».
Con la sua esperienza e il suo esempio, Casarin ha sempre provato a sovvertire questo storico dogma: «Anche i giocatori ti stanno vicini se capiscono che non ti poni nei loro confronti con superiorità e sei onesto, quindi bisogna stare loro vicino. Questo, tra l’altro, abbassa il numero dei falli. Negli anni ’50 si fischiava, puniva e poi si andava via. Poi con la tv si misero in evidenza gli errori, rinnovando le regole grazie a uno strumento che è comunque anche a nostra disposizione. Dal 1990 agli anni 2000 i miglioramenti sono stati notevoli, con il tempo di gioco effettivo che è salito da meno di 50 a 60 minuti.Ma la tv ha anche una debolezza, rispetto a stare in campo. È cieca, non vede tutto ciò che succede attorno a ciò che le riprese stanno mandando in onda. E può essere anche sorda. Ma il fatto che ci sia, condiziona le scelte dell’arbitro».
Come può quindi la figura del direttore di gara essere virtuosa, anche e soprattutto nei campi di periferia e tra i giovani e i giovanissimi? La ricetta di Casarin, in tal senso, è chiara: «Il calcio è distratto dai soldi e dalla volontà di vincere sempre e comunque. E questo fa scomparire l’arbitro. Ai bambini, poi, non si deve dare il culto della vittoria. La prima cosa che dovrebbero imparare, ancor prima che a vincere, è a perdere. Da questo punto di vista la cosa migliore sarebbe forse lasciarli giocare senza nemmeno un arbitro, e anche senza i genitori che spesso diventano un elemento nocivo e di stress per loro. Bisogna invece richiamarli a giocare. Il cuore dello sport è questo, non calcare i campi con la paura di un arbitro autoritario o del giudizio di un genitore che ti inculca l’idea che non devi divertirti, ma battere il tuo avversario».
Paolo Casarin durante il suo intervento all’Università di Bergamo (credits: Academic Football Lab – UNIBG)